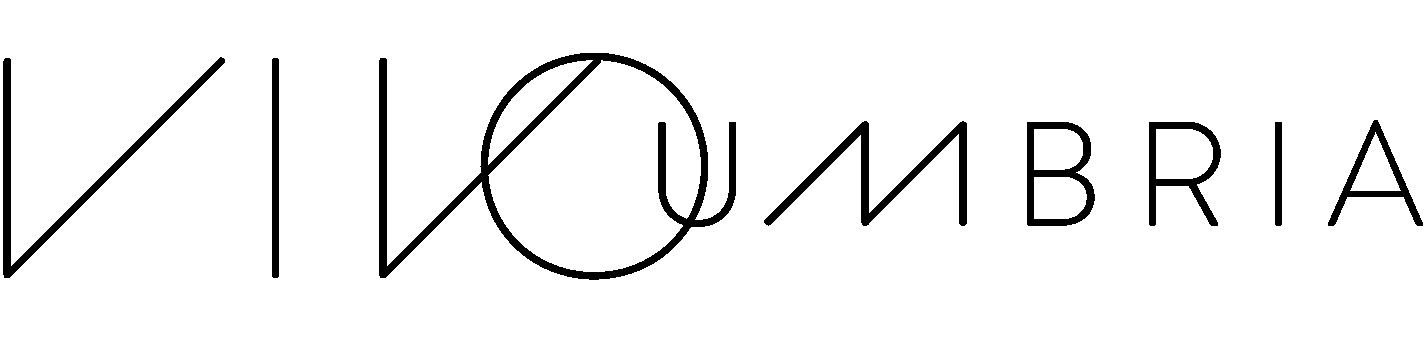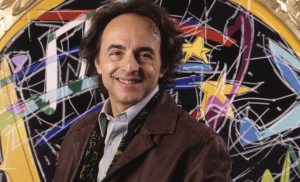TERNI – Dicono siano stati 108 i bombardamenti degli alleati americani subiti da Terni tra l’11agosto 1943 e il 6 giugno 1944 (data della liberazione). Bomba più, bomba meno, se l’obiettivo principale era – a detta degli storici – la linea ferroviaria, danni collaterali una città che per metà non c’era più. Servizi interrotti; assenza di acqua e energia elettrica; carenza di cibo; la tragica conta dei morti e dei feriti; le bombe che continuavano a cadere.
Per lunghi mesi, chi era rimasto, al suono dell’allarme scappava verso il rifugio più vicino.
Nel maggio 1943, ne sono censiti 81: rifugi pubblici, come quello di Palazzo Morelli, in via Silvestri, per chi si fosse trovato per strada al suono della sirena; collettivi, per chi era al lavoro, come quello della Foresteria della Terni, in corso Tacito; scolastici, come quello sotto il Liceo classico, in viale Fratti. Offerti dalla natura quelli ricavati all’interno delle grotte del Nera. Luoghi sotterranei, spesso del tutto inadeguati allo scopo, nei quali, giorno dopo giorno, attendere terrorizzati che gli aerei sganciassero il loro carico di morte e suonasse il cessato allarme.
“I sotterranei che in tempo di guerra facevano da rifugio sono più numerosi di quello che si può pensare. C’erano in via Roma, a Porta Sant’Angelo, in Largo Falchi… Alcuni sono ancora accessibili; altri sono stati murati subito dopo la guerra. Ce ne sono sicuramente altri ancora, anche se non ne conosciamo l’esatta ubicazione. Quello in area via Aminale – via dell’Arringo, che è chiuso, sta per essere demolito insieme al complesso che lo ospita. Un vero peccato perché si tratta di beni culturali a tutti gli effetti – spiega Paolo Boccaccini, referente per le cavità artificiali del Gruppo Grotte “Pipistrelli” del Cai di Terni.
Fino a qualche anno fa, il Gruppo era partner del Comune di Terni, dell’Isuc (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea) e de La Siviera (Laboratorio giovani comunicazione Blob) nel progetto Terni sotterranea, un percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio ipogeo ternano che si è interrotto nel 2019.
“La ricerca sui rifugi – racconta Boccaccini – comincia venticinque anni fa, quando il mio interesse di speleologo si rivolge al sotterraneo artificiale e mi metto a studiare le carte”.
Inizia nel 2012, con l’apertura al pubblico dei rifugi di Palazzo Carrara e Palazzo Morelli promossa dal Comune di Terni, l’attività divulgativa rivolta alla cittadinanza, e soprattutto alle scuole, corroborata dagli studi di Angelo Bitti, Gianni Bovini, Marco Venanzi sulle fonti documentarie relative alla II Guerra mondiale conservate nell’Archivio di Stato di Terni, negli archivi comunali, in quelli dell’Isuc, della Questura, della Procura.
“Il rifugio di Palazzo Carrara – continua Boccaccini – era utilizzato dal personale e dai detenuti del carcere. Poi, è stato tappato con la sabbia. Per renderlo accessibile, abbiamo svuotato la discenderia, liberato il vano dai detriti, messo tutto in sicurezza. Per ricreare l’ambientazione, abbiamo simulato una trincea con 125 sacchi di sabbia, e con dei led abbiamo ottenuto l’illuminazione che si trovava realmente nei rifugi dell’epoca. Per i 240 visitatori che sono entrati a gruppi di 10-12 alla volta è stato molto emozionante. Per noi, un incentivo a ripetere l’esperienza e allargare l’itinerario”.
L’idea è di realizzare, nel tempo, un museo diffuso sotterraneo, fruibile dai cittadini in particolari periodi dell’anno.
Negli anni successivi, nel rifugio di Palazzo Carrara arrivano gli elmetti, le maschere antigas, i telefoni da campo. Le ricerche proseguono, le visite periodiche si succedono. Si interrompono nel 2019 per il covid. Non sono più riprese.
“Ci siamo tornati nel 2022, per un’ispezione. È tutto marcio – dice sconsolato Boccaccini. Ci vorrebbe un po’ di aiuto da parte del Comune, ma non vediamo segnali positivi, neppure per la ripresa delle visite guidate rivolte alle scuole, che pure potrebbero essere facilmente messe a sistema con quelle che si svolgono alla Fabbrica d’Armi. Non per educare alla guerra, casomai il contrario: per far capire quanto è brutta“.
Motivo d’orgoglio, in ogni caso, aver contribuito alla scoperta di una città sotterranea popolata da un’umanità in bilico nel periodo più tragico della storia recente di Terni.
“Dopo il primo bombardamento – prosegue – le persone sono scappate in massa. Gli sfollati nei paesetti limitrofi erano tantissimi. Per quelli che erano rimasti, o che facevano i pendolari per raggiungere i luoghi di lavoro che non erano stati colpiti, era questione di vita o di morte avere un posto dove ripararsi. In alcuni rifugi abbiamo trovato segni di lunga permanenza. In altri messaggi d’amore. Visitarli significa entrare in contatto con la vita quotidiana dei ternani in quel periodo; conoscere le modalità difensive previste dalle istituzioni; farsi delle domande”.
Colle delle Grotte
La scoperta di rifugi antiaerei tra le grotte del tratto fluviale tra Ponte Santa Maria Maddalena e Ponte di Cervara si deve alla lettura de Le acque pubbliche, gli acquedotti di derivazione e le utilizzazioni idrauliche del territorio di Terni, opera del 1936 dell’ingegner Guido Bergui che cita la presenza di “ruderi di tratti d’antichissima galleria d’un canale scomparso” di origine riconducibile all’epoca romana.
“A partire dallo studio di quel testo – dice Boccaccini – abbiamo iniziato le esplorazioni nella zona. Nella mappa del catasto gregoriano si chiamava Colle delle Grotte. Abbiamo individuato così altri quattro tratti dell’antico canale e in quella circostanza abbiamo scoperto alcune grotte scavate a mano. Ancora oggi sono visibili le nicchie dove venivano allestiti letti di fortuna. Che fossero utilizzate come rifugi antiaerei lo confermano fonti scritte e orali”.
Condotta dall’archeologo Valerio Chiaraluce, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, documentata da Paolo Gagliardi, speleologo e fotografo ufficiale del Gruppo, l’indagine ha portato alla realizzazione di una mappa dell’area e al docufilm Colle delle Grotte a cura di Lorenzo Bernardini, Greca Campus, Michele Manuali, Paolo Sfirri, Massimiliano Gasperini e Paola Patrizi.
Le immagini mostrano il rifugio della Bifora, un sotterraneo ricavato allargando un precedente canale idraulico, derivazione laterale del canale Cervino; quello denominato Latrina per la presenza di rudimentali servizi igienici; quello di Villa Sant’Angelo, sede del comando tedesco, dove venivano ammassate armi e munizioni.
“Ci auguriamo di poter riprendere presto l’attività con le scuole e tornare a raccontare questo spaccato di vita che appartiene alla nostra storia. La guerra ha inciso non poco sul nostro territorio. Non si può dimenticare” – conclude Paolo Boccaccini.
Lorella Giulivi
Contributo fotografico: Paolo Gagliardi