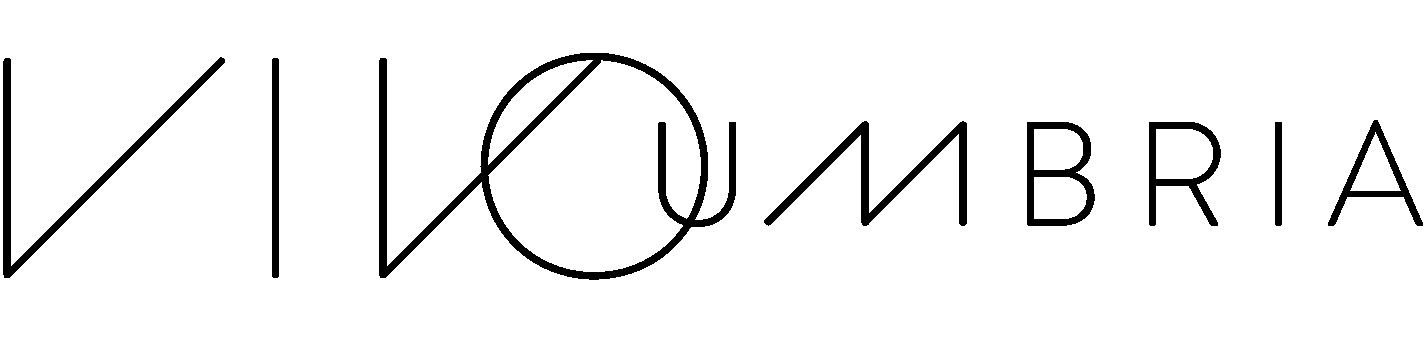Quotidianamente si è soliti compiere, tramite la semplice pressione di un polpastrello, una smisurata quantità di azioni di ogni tipo; e-mail, messaggi, post, commenti, acquisti e ricerche sono a portata di dito in una realtà, la nostra, in cui la digitalizzazione ha permeato le nostre vite a tutto tondo; si pensi all’estrema facilità di acquisto di cui si dispone grazie all’e-commerce i cui negozi virtuali, avendo ormai sbaragliato gran parte della concorrenza “fisica”, offrono una più ampia gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi. La stragrande maggioranza degli utenti è ben pronta a sfruttare ogni forma di comodità e agevolazione offerta dalla tecnologia, non ponendosi alcun vincolo né etico né riguardo la trattazione dei propri dati sensibili. Ormai non si fa profezia alcuna quando si affronta la tematica secondo cui online, quando qualcosa è gratis, la merce siamo noi; si pensi difatti a Google e a Facebook e si rifletta sul fatto che un’ingente quantità di servizi rapidi ed efficienti viene offerta gratuitamente, o meglio, attraverso un apparente gratuità. Si dispone difatti di un servizio dove il “dazio” è rappresentato dai nostri dati intesi come email, foto, messaggi, ricerche, posizioni ecc. tutti prontamente analizzati da un elaborato algoritmo al fine di carpire ciò che ci piace e ciò che non ci piace, con chi parliamo più spesso, che cosa ricerchiamo, dove andiamo ecc. In altri termini, le informazioni che tutti noi, consapevolmente o meno, forniamo ai grandi dell’high-tech, costituiscono, per questi, una vera e propria linfa vitale, pronta ad essere consegnata a terze parti per fini commerciali. Anche i meno abili nell’utilizzo del mezzo informatico riescono, ormai, a padroneggiare, quantomeno ad un livello base, i principali strumenti della rete quali app di messaggistica, client e-mail, social media e mappe; tuttavia, come è noto, questi servizi vengono offerti in regime monopolistico dove, lo scenario che si configura, è quello secondo cui non vi è spazio al di fuori dell’universo Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Le consuetudini d’uso dovute ad efficienza e comodità dei servizi offerti dai cosiddetti “Big Five” (conosciuti anche con l’acronimo di GAFAM) hanno assuefatto milioni di utenti-consumatori ad una prassi quotidiana fatta di azioni e gesti che tengono conto solo ed esclusivamente del servizio, tralasciando, purtroppo, ogni forma di interesse per la tutela dei propri dati sensibili; erroneamente si è soliti pensare che non si ha nulla da nascondere, ma quando si parla di dati personali e, più in generale, di privacy, sostenere di non avere nulla da nascondere sarebbe come a dire, parafrasando Edward Snowden, di poter fare a meno della libertà di parola in quanto non si ha nulla da dire. Continuare ad utilizzare sempre quel servizio, solo perché pre-installato sul proprio smartphone, o solo perché rappresenta quello più utilizzato, costituisce un efficace strumento che permette, a questi grandi accumulatori di big data, lo stradominio nel mondo virtuale (e non solo). La semplice non conoscenza del funzionamento di servizi ad apparente costo zero, o l’ancor più grave non curanza di ricorrere, magari, ad alternative più accorte e, perché no, open-source, genera un vantaggio iniziale ai dominatori sui dominati che non lascia molto spazio alla speranza di una futura presa di coscienza di massa verso un’esperienza d’uso consapevole. Risulta pertanto evidente che sarebbe necessaria una vera e propria educazione digitale per giovani e non, finalizzata ad avviare verso un utilizzo etico della tecnologia e dei suoi strumenti, ponendo così le basi per una coscienza collettiva ben consapevole dei rischi e delle violazioni da parte di una ristrettissima cerchia di aziende private (senza parlare della sorveglianza governativa) che, oltre a riscontrare costanti impennate nei propri profitti, hanno iniziato, già da troppo tempo, ad esercitare un temibile peso politico e sociale, di certo non imparziale. Ne è un esempio la recente censura, da parte di Facebook e Twitter, ai danni dell’uscente presidente statunitense Donald Trump la quale costituisce un’azione che niente ha a che fare con il sano esercizio democratico di cui, come è ovvio, la censura ne rappresenta una chiara negazione; al di là del giudizio politico sulla parte oggetto del “bavaglio”, la presa di posizione dei CEO Marck Zuckerberg e Jack Dorsey segna un sempre più ingombrante ruolo da parte di società private aventi un’arbitraria pretesa di stabilire cosa sia giusto e non giusto dire; e se è vero che la libertà di parola è un diritto del quale sarebbe opportuno non abusare, è altrettanto vero che la possibilità di sentenziare se sia lecito o meno giudicare come inopportuna un’opinione espressa da un rappresentante politico, non può essere esercitata da un’azienda privata (che di certo imparziale non è); una scelta alquanto discutibile specie se al ruolo di moralizzatori si ergono soggetti il cui principale interesse è strettamente quello personale. Del resto se si ripercorressero le vicende di vita che hanno portato i vari Gates, Jobs, Bezos e Zuckerberg alla costruzione dei propri imperi, si comprenderebbe che l’unica “fede” professata da questi personaggi, e loro affini, è solo ed esclusivamente quella del profitto. Pertanto, oltre che detentrici di gran parte dei nostri dati sensibili, le onnipotenti multinazionali dell’IT, e i rispettivi CEO, stanno progressivamente occupando un sempre maggior rilievo sociopolitico, ricorrendo anche a pratiche ben lontane da quegli ideali di facciata di cui, quando fa comodo, si ergono a paladini. Se quindi il precedente auspicio, verso un utilizzo etico della tecnologia e dei suoi strumenti, possa apparire ad oggi come inverosimile, sarà allora opportuno sperare di attendere, se mai arriverà, il giorno in cui proteggere la privacy sarà più redditizio del violarla?