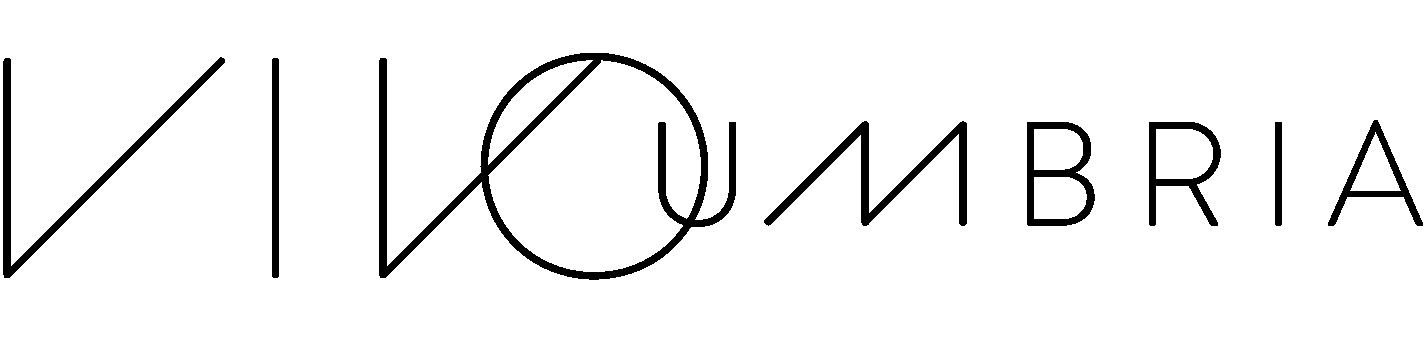In questi giorni, la pubblicazione sulla rivista Architecural Digest di un saggio di Ettore Sottsass Jr. scritto alcuni anni fa per la rivista “Terrazzo” riproposto in occasione della mostra allestita a Milano dal titolo “Monumental Memento” su Architettura e Fotografia, ha riportato al centro all’attenzione l’opera di Aldo Rossi mettendo in evidenza una delle sue opere più emblematiche: il centro direzionale di Fontivegge a Perugia.

Non ho l’intenzione di avventurarmi in giudizi di valore – se non esprimendo qualche personalissima opinione – circa l’opera di uno dei maggiori protagonisti dell’architettura contemporanea, primo italiano ad essere insignito nel 1990 del premio Pritzker – considerato il Nobel dell’Architettura – a cui seguirono una lunga lista di riconoscimenti da ogni parte del mondo e importanti mostre retrospettive nei più prestigiosi musei. Come è noto, la sua improvvisa scomparsa non gli ha permesso di proseguire una carriera professionale fino a quel momento coronata da brillanti successi. Tuttavia, considerato il rinnovato interesse per l’opera di questo straordinario protagonista dell’architettura – mai venuto meno da parte della critica più autorevole – mi sono domandato perché una personalità così importante sia stata pressoché condannata all’oblio, quando non anche invisa o denigrata, nella città in cui ha realizzato una delle sue opere più rappresentative. Non avendo trovato una spiegazione convincente, ho pensato che la ragione principale sia in parte conseguenza del provincialismo che purtroppo imperversa da alcuni anni in una città che, in un passato relativamente recente, era stata capace di esprimere iniziative di indubbio valore, sia in campo culturale che in altri campi incluso quello economico.
Occorre peraltro convenire sul fatto che la costruzione del centro direzionale di Fontivegge si sostanziò in circostanze del tutto particolari quali, tra le altre, l’approdo di Carlo de Benedetti a Perugia che meriterebbero di essere ricordate – ma non in questa sede – le quali ne hanno in parte condizionato negativamente l’impostazione iniziale. Il progetto effettivamente realizzato è risultato privo di alcuni elementi fondamentali come il teatro, parzialmente incompiuto nella sua componente residenziale che avrebbe senz’altro migliorato la vivibilità dell’intero quartiere, oggi vissuto solo in orario di ufficio, e soprattutto costruito con materiali e tecnologie di bassa qualità che trasmettono un immagine di scarso valore formale avvallando l’idea di un progetto concepito e realizzato principalmente per scopi immobiliari e speculativi mettendo in ombra il suo indiscusso valore culturale.

Ho conosciuto alcuni anni fa Aldo Rossi avendolo incontrato in un paio di occasioni nel suo studio di Milano quando l’allora Presidente della Provincia di Perugia Marcello Panettoni, da appassionato della buona architettura e mio caro amico, aveva in animo di affidare il progetto del nuovo liceo scientifico di Città della Pieve ad un professionista di chiara fama (oggi diremmo un “Archistar”). In quegli anni, avevo avuto la possibilità di frequentare saltuariamente per ragioni di studio e di lavoro alcuni grandi protagonisti dell’architettura italiana della generazione dei “Maestri” come Ridolfi, Gardella, Portoghesi, Piano, Botta, e molti altri meno noti ma non meno importanti.

La scelta, anche su mia istigazione, cadde alla fine su un altro grande personaggio della scena architettonica internazionale come Mario Botta poiché l’incontro con Rossi non mi aveva suscitato particolari entusiasmi pur avendo letto con molta attenzione ed apprezzato alcuni dei suoi saggi più celebrati come “L’Architettura della Città” e “Autobiografia Scientifica” tradotti e pubblicati in ogni parte del mondo. Ho impiegato del tempo, grazie all’ausilio di alcune buone letture, per cogliere fino in fondo il valore delle sue opere, ivi incluse quelle più controverse come il Cimitero di San Cataldo a Modena, e soprattutto per comprendere appieno il contributo teorico offerto da Rossi al dibattito sulle tendenze dell’architettura portando, forse per la prima volta, il nostro paese al centro dell’attenzione internazionale. Non sono rimasto sorpreso più di tanto nell’assistere alle critiche né nel cogliere il disorientamento in una parte dell’opinione pubblica al cospetto delle sue opere così inconsuete perché l’architettura, come ogni linguaggio, richiede studio e conoscenza. Ho invece condiviso la critica per la sciatteria che ha caratterizzato la costruzione degli edifici e provato una certa irritazione per la disattenzione della città che non si è mai dimostrata particolarmente interessata al completamento del progetto secondo le originarie previsioni urbanistiche.

Eppure, riassumendo in pillole il contributo offerto dal grande Maestro al dibattito teorico sull’architettura, si può affermare con certezza che Aldo Rossi, al pari di altri grandi personaggi come Louis Kahn, è stato uno dei primi architetti a capire che una stagione – quella iniziata con il Movimento Moderno e degenerata nel cosiddetto “International Style” – era per sempre finita e che era necessario rompere il connubio tra forma e funzione che per lunghi anni ne aveva ispirato la prassi operativa.
Rifondare la disciplina emancipandola da ogni subalternità al funzionalismo e al tecnicismo per riportare al centro dell’attenzione l’immagine della città, la sua memoria, la sua forma e perfino la sua “teatralità” – perché, come egli stesso ci ricorda in uno dei suoi saggi più celebrati osservando i monumenti del passato, la pluralità di funzioni che tali opere possono ospitare “siano per così dire del tutto indipendenti dalla sua forma e che però è proprio questa forma che ci resta impressa che viviamo e percorriamo e che a sua volta struttura la città” – questa, in estrema sintesi, è forse la sua lezione più importante.
Si potrebbero scrivere molte altre cose su di lui ma il pensiero di Rossi unitamente al contributo teorico di altri architetti che parimenti meriterebbero di essere ricordati come Robert Venturi, indicheranno le nuove coordinate dell’agire e del fare architettura orientando intere generazioni di professionisti nel mondo. Per questo personale ricordo e per altre ragioni che tralascio ho accolto l’invito del Direttore di questa rivista a scrivere queste poche righe per ricordare una figura – quella di Aldo Rossi – che la città di Perugia dovrebbe invece onorare come merita.
Fontivegge è continuerà ad essere, nonostante tutte le contraddizioni e le critiche anche fondate di cui Aldo Rossi non porta alcuna responsabilità, uno dei luoghi simbolo della città di Perugia. Ed allora, piuttosto, verrebbe da domandarsi che cosa è accaduto in questi anni – e non parlo solo dei tempi più recenti – ad una città che solo qualche decennio fa era in grado di esprimere idee e rappresentare sé stessa attraverso progetti di respiro internazionale di cui Fontivegge per l’architettura è solo un primo parziale esempio: una città che rivoluzionava il modo di concepire la mobilità urbana con le scale mobili e poi, pur con risultati meno brillanti, con il Mini-Metrò; che inventava dal nulla uno dei più celebrati festival di musica Jazz al mondo e che organizzava eventi artistici di respiro internazionale come l’incontro tra Alberto Burri e Joseph Beuys di cui è appena ricorso il quarantennale nella quasi totale indifferenza; che con i suoi imprenditori visionari era in grado di rivoluzionare l’industria tessile e l’abbigliamento sportivo, realizzare uno stadio di calcio in soli quattro mesi, nonché inventare il primo parco a tema in Italia; che in tempi meno recenti accettava la sfida di riscrivere la storia della psichiatria, solo per ricordare solo alcuni degli esempi più eclatanti.
Erano quelli i tempi in cui la città e le sue classi dirigenti – non solo quella politica sia chiaro – avevano il coraggio e l’ambizione di scommettere sul futuro.
Ma questa è un’altra storia.