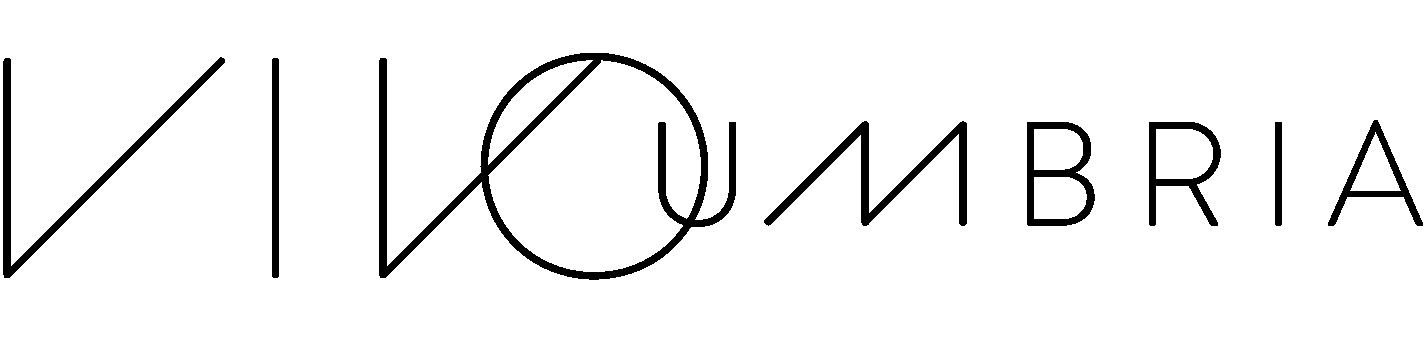PERUGIA – I detenuti potranno essere sì e no un centinaio, ma le prime file sono tutte occupate da quelli che vengono da fuori. Giornalisti, operatori, educatori, funzionari, volontari: sono arrivati prima, e si sono messi davanti. Poi pian piano l’ala sinistra della platea si riempie di ragazzi scortati dagli agenti della Penitenziaria, poco dopo si riempie anche l’ala destra. Dire ragazzi sarebbe dire uomini, ma quasi tutti molto giovani, e quasi tutti stranieri. Maghrebini, esteuropei, un paio di subsahariani. C’è anche qualche italiano, ma pochi. Il carcere è questo, è una Babele in cui finisce soprattutto chi l’arte di arrangiarsi la deve imparare con una lingua che non è quella del posto in cui si è ritrovato a vivere.
Vinicio Capossela ha gli occhi bassi, e li terrà bassi per tutto il pomeriggio. Lo presentano, e lui abbassa lo sguardo, ogni tanto si tira i riccioli sulle tempie che spuntano dal cappello a tese larghe. Per qualche strana ragione sembra più giovane di qualche anno fa. Vinicio è qua per cantare, eppure qualcosa, all’inizio, deve pur dire. Di fronte però ha troppa gente, e gente troppo diversa. “Due tipi di pubblico insieme”, lo dice anche lui, e trovare la semantica adatta a tutti è un’impresa. A ben vedere, in questa sala polivalente in cui Brunello Cucinelli prima di desistere aveva pensato di realizzare un laboratorio di sartoria, non ci sono solo due tipi diversi di pubblico. Nemmeno due mondi diversi. Sono due dimensioni della realtà, che convivono assurdamente. Eppure i detenuti lo ascoltano, o ci provano, mentre parla di minorità e di Illuminismo, dei libri che ha letto e degli intellettuali che ha incontrato, di cosa gli si forma in testa quando pensa alla prigione. Sono qui per lui, ma non sono qui per lui. “Io che ne so chi è quello che canta. Sono straniero”, dice un quarantenne rumeno un po’ in disparte, gli occhi azzurrissimi e i capelli quasi a zero. Chissà in base a quali criteri sono stati scelti, gli spettatori di questo lunedì pomeriggio di luglio, tra gli oltre trecentocinquanta ospiti della casa circondariale di Capanne.
Il concetto di minorità è poi la cerniera tra i discorsi e la musica. In carcere l’uomo è davvero ridotto ai minimi termini, “vivere un tempo solo da consumare è disumano”. Capossela si siede al piano e comincia a suonare. Comincia proprio da Minorità, canzone contenuta nel suo ultimo disco Tredici canzoni urgenti uscito una manciata di settimane fa. “Ho chiesto la penna al secondino”: le prime parole sono queste, e chi le ha capite è per forza tirato dentro alla piccola storia di un uomo come loro che a un certo punto chiede “che sarebbe mai successo a lei se solo fosse nato dove sono nato io?”. È la domanda chiave di tutto, in fondo. E la forza dell’immedesimazione, nell’arte, sarà elementare, ma sa essere enorme. Vinicio prosegue per un po’ con le sue “canzone sfuse”, canta di Tequila Bum Bum e vite che vanno a scatafascio, butta là il valzerino di Pena del alma. Il primo nodo si scioglie davvero quando fa Che coss’è l’amor, è qualcosa che ormai appartiene all’aria, che lo vogliamo o no è anche roba nostra, di tutti, e infatti laggiù in fondo c’è anche un’agente che dondola la testa e canticchia il ritornello. Il secondo dei tanti nodi che ci sentiamo addosso e in gola viene via subito dopo, perché Capossela canta Core ingrato, e in terza o quarta fila c’è un uomo in là con gli anni, uno dei veterani, verrebbe da pensare, che la canta a bassa a voce insieme a lui. La maglia azzurra, i pantaloni corti, per un attimo sembra quasi Kvaratskhelia. Da qui in poi è tutto un crescendo, con Corvo torvo e Capossela che gracchia a squarciagola cominciano le ovazioni, con quel gioiello folle di Marajà siamo quasi al tripudio. Ed è adesso, mentre il cantautore si alza e ringrazia e chiede dove può trovare un bagno, che comincia un’altra storia.
Quando Vinicio torna in sala trova il palco, che poi non è altro che un fazzoletto di pavimento delimitato da strumenti e amplificazione, occupato da due sconosciuti. Sconosciuti a lui, ma non al grosso della gente che gli sta intorno. Sono Pasquale alla chitarra e Dorian alla voce, allievi del laboratorio di musica che si lanciano in due pezzi scritti da loro. Il primo si intitola La vita non è una passeggiata, ed è una canzone d’amore. Il secondo è un assolo di Pasquale: “perché per me sei la più bella, più lucente di una stella”. Durante l’esibizione il brusio sale, gli animi si eccitano, qualche dubbio ribolle, ma gli applausi che scrosciano alla fine dimostrano che in qualche modo si è rotto un muro. E infatti ora c’è quasi la fila per farsi avanti. Il ragazzo che si prende la scena è giovanissimo, nordafricano. La sua maglietta è completamente occupata dalla testa di un leone incoronato, indossa pantaloni aderenti della Nike, in testa ha un cappellino viola con la scritta “Roma”. “Faccio un rap in arabo”, dice. Parte, è un treno, è una bomba. Andrea Lamacchia, che ha accompagnato per tutto il tempo Capossela con il suo contrabbasso, sgrana gli occhi e si mette a improvvisare accanto a lui. Altra ovazione, quindi, e ora arriva un altro maghrebino, ha qualche anno in più e una distesa di capelli ricci in testa. Canta un po’ in italiano e un po’ in arabo, un po’ di rap e un po’ di melodia, e quando arriva al ritornello ci sono almeno altri dieci compagni in platea che cantano con lui. “Clandestino, perché senza soggiorno. Perché senza la mamma. Perché senza ritorno”. Potente, e se ne accorge anche Capossela, che parlotta con il ragazzo con la testa di leone e se lo porta di nuovo sulla ribalta. Un altro pezzo, ancora tra l’arabo e l’italiano, Vinicio al piano e Lamacchia ai toni bassi, poi quello fa cenno di voler rimanere da solo e loro l’accontentano, la canzone finisce e sulla faccia cupa del detenuto-bambino si allarga un sorriso.
Chiudere i giochi tocca a Capossela, e non è facile come non era stato facile aprirli. Prima di ringraziare Patrizia Marcagnani, amica di una vita che ha voluto con forza questo concerto, si rimette al piano e suona Con i tasti che ci abbiamo. È un brano sulle possibilità sterminate dell’immaginazione, calza a pennello. Dopo l’ultima nota Vinicio alza finalmente gli occhi, e gli occhi brillano. Ma non gli basta, diventa improvvisamente chiaro che questa in fondo per lui è la parte più semplice perché questo ormai è un vero spettacolo, Vinicio sente che manca ancora un tassello, si riavvicina al pianoforte e intona la preghiera d’amore di Ovunque proteggi. “Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo”. Tornerà il tempo di non consumare e basta il tempo, sembra suggerire. Sì, forse, ma chissà quando e chissà come. Il pomeriggio è stato un incanto oscuro da cui per chi riattraversa la spianata di Capanne e varca la soglia che per poche ore lo ha separato dal mondo, dalla dimensione reale di ogni giorno, non sarà facile uscire. Per gli altri, per quelli che alla fine se ne sono tornati in cella, l’incanto ha un sapore diverso, che visto da qui non dovremmo nemmeno avere la pretesa di ipotizzare.